| Pubblicato su: | Nuova Antologia, anno LXVII, fasc. 1439, pp. 3-21 | ||
| 1 - 2- ( 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9-10 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21) |
|||
| Data: | 1 marzo 1932 |
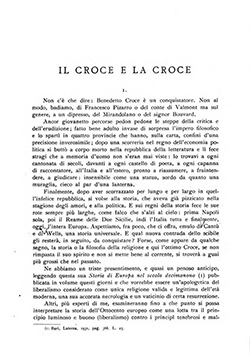
pag.3

pag.4

pag.5

pag.6

pag.7

pag.8

pag.9

pag.10

pag.11

pag.12

pag.13

pag.14
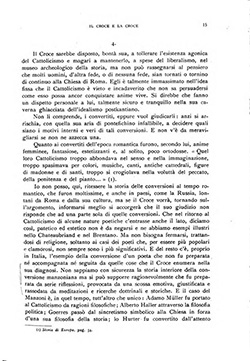
pag.15
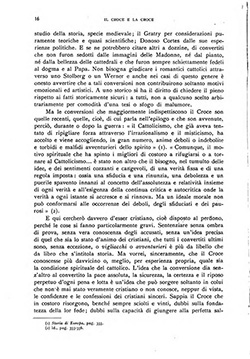
pag.16

pag.17
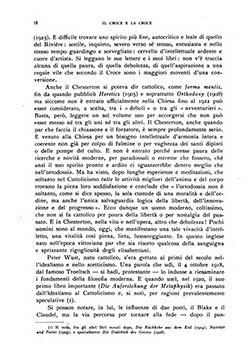
pag.18

pag.19

pag.20

pag.21
3
Non c'e che dire: Benedetto Croce e un conquistatore. Non al modo, badiamo, di Francesco Pizarro o del conte di Valmont ma sul genere, a un dipresso, del Mirandolano o del signor Bouvard.
Ancor giovanetto percorse pedon pedone le steppe della critica e dell'erudizione; fatto bene adulto invase di sorpresa l'impero filosofico e lo spartì in quattro provincie che hanno, sulla carta, confini d'una precisione inverosimile; dopo una scorreria nel regno dell'economia politica si buttò a corpo morto nella repubblica della letteratura e lì fece stragi che a memoria d'uomo non s'eran mai viste: lo trovavi a ogni cantonata di secoli, davanti a ogni castello di poeta, a ogni capanna di raccontatore, all'Italia e all'estero, pronto a riassumere, a fraintendere, a giudicare: insensibile come una statua, sordo da quanto una muraglia, cieco al par d'una lanterna.
Finalmente, dopo aver scorrazzato per lungo e per largo in quell'infelice repubblica, si volse alla storia, che aveva già pizzicato nella stagione degli amori, e alla politica. E sui regni della storia fece le sue rote sempre più larghe, come falco che s'alzi al cielo: prima Napoli sola, poi il Reame delle Due Sicilie, indi l'Italia tutta e finalmente, oggi, l'intera Europa. Aspettiamo, fra poco, che ci offra, emulo di Cantù e di Wells, una storia universale. E qual nuova contrada dello scibile gli resterà, in seguito, da conquistare? Forse, come appare da qualche segno, la storia o la filosofia della religione e qui l'ottimo Croce, se non rimpasta il suo spirito e non si mette bene al corrente, si troverà a guai più grossi che nel passato.
Ne abbiamo un triste presentimento, e quasi un penoso anticipo, leggendo questa sua Storia di Europa nel secolo decimonono 1 pubblicata in volume questi giorni e che vorrebbe essere un'apologetica del liberalismo considerato come unica religione valida e legittima dell'età moderna, una sua accorata necrologia e un vaticinio di certa resurrezione.
Altri, più esperti di me, esamineranno fino a che punto si possa interpretare la storia dell'Ottocento europeo come una lotta tra ii principio luminoso e buono (liberalismo) contro i principi tenebrosi e malvagi
4
(Cattolicismo, Democrazia, Reazione). Di solito, nella storia fatta sul serio, lo schema manicheo della lotta tra il bene e il male è un'eresia che sorge negli spiriti semplicisti, tante son le fila, e tanto intrecciate, che formano il tessuto delle grandi società umane. E si dovrà vedere, fondandosi sulla complessità dei fatti, se il trionfo (apparente) del sistema liberale — che lo stesso Croce restringe a poco più di quarant'anni: 1871-1914 — fu il primo esperimento (fallito) di un'idea destinata a sopravvivere, anzi a rinascere per non più morire, o non piuttosto una parentesi d'eccezione, dovuta a particolari congiunture sociali ed economiche che interruppero, per un momento, la struttura costante degli Stati e che non si ripresenteranno, per quel che oggi si può supporre, mai più.
L'intenzione mia non è, ora, di scandagliare questi e simili problemi si bene di giudicare i giudizi del Croce intorno alla religione e al Cattolicismo e in particolar modo intorno al significato dei ritorni alla fede cattolica. Che nel suo libro egli si dimostra se non avversario radicale della religione — purchè questa sia intesa a suo modo — non certo amico del Cristianesimo e sopratutto di quell'autentico e totale Cristianesimo ch'e la sostanza viva della Chiesa di Roma.
Ma voglio, prima di tutto, sinceramente lodarlo per aver dato posto nella sua Storia di Europa a quelle vicende e correnti spirituali, e non solo religiose, che gli storici comuni hanno la pessima usanza di tralasciare, o di sbrigare in poche note complementari, come se la storia degli uomini non fosse principalmente — non dico unicamente — storia d'idee, d'opinioni, di credenze e di sentimenti. Conosco storie d'Italia e d'Europa dove, ad esempio, i moti religiosi e filosofici son taciuti come indegni d'attenzione e perfin di ricordo e dove della Chiesa si parla, e con insufficiente informazione e profondità, soltanto per le relazioni dirette, spesso puramente esteriori, che ebbe colla politica degli Stati, come s'ella non fosse essenzialmente una società spirituale che ha colla politica vera e propria rapporti forzati, o per lo meno null'affatto essenziali alla sua natura e alla sua missione.
La Storia di Europa del Croce è, per fortuna, piuttosto storia intellettuale e morale del secolo scorso che non racconto delle vicende pubbliche e dei fatti vistosi, come usano i più, e comprende perciò quegli avvenimenti meno visibili ma ben più importanti, che non siamo avvezzi a incontrare in simili opere.
Da molti anni il Croce va discorrendo di «religiosità», e anche di «religione» — ch'egli tende, secondo il suo costume, a identificare malgrado (o a causa) che si tratti di due opposti — col proposito di operare
5
una doppia dissociazione: nell'ordine teoretico separare la «religione» da ogni filosofia del trascendente e, nell'ordine pratico, da ogni Chiesa, e prima di tutto dal Cattolicismo. Dio non esiste o esiste solo nel cuor dell'uomo — è, insomma, l'uomo nella sua ricerca incessante del vero — e le Chiese non sono che avanzi di culture sorpassate e morte, ridotte ormai a pure macchine devozionali e politiche. Alla religione cristiana va sostituita la «religione umana»: lo spirito dell'uomo è Dio e Benedetto è il suo profeta.
È una musica, veramente, che da qualche secolo, e specialmente da cent'anni a questa parte, è stata suonata da molti suonatori e su diversi strumenti ma il Croce tenta di armonizzarla con più filosofiche intavolature. E per riuscire a esser mezzano del doppio desiato divorzio ricorre a un'amputazione spicciativa: che dico amputazione? a uno squartamento tale che della misera religione rimane intatto, si e no, appena il busto.
Grande è, indubbiamente, il fascinum del Croce dialettico ma non può arrivare al punto di cambiare, con inaudite e arbitrarie sottrazioni, il significato d'una parola consacrato dai secoli nelle maggiori lingue del mondo e da sei millenni d'esperienza storica. Poichè, secondo il nostro evangelista del liberalismo, l'«essenziale ed intrinseco d'ogni religione... risiede sempre in una concezione della realtà e in un'etica conforme» e si deve prescindere «dall'elemento mitologico, pel quale solo secondariamente si differenziano dalle filosofie». E, non contento, aggiunge che «personificazioni, miti, leggende, dommi, riti, propiziazioni, espiazioni, classi sacerdotali, paludamenti pontificali e simili non appartengono all'intriseco e malamente vengono astratti da particolari religioni e posti come esigenze di ogni religione» 2.
Ridotta questa, come si vede, a una semplice teoria della realtà e ad una regola morale non è difficile presentare il liberalismo come una vera religione, anzi come l'unica vera, benchè ci sia da obiettare, anche ammesse le premesse, che nel liberalismo, semplice metodo di governo e tutt'al più aspirazione alla libertà politica, non si riscontri una «concezione della realtà» intesa in senso filosofico, cioè universale.
Ma quella potatura spietata che il Croce esercita sul concetto di religione non possiamo assolutamente lasciargliela passare e non già per stimoli apologetici o confessionali ma proprio per ragioni storiche, oltre che per l'esigenze della chiarezza logica e linguistica. Lasciamo pur dapparte, per il momento. l'elemento mitologico — chè si potrebbe sostenerne l'assenza nel Confucianismo e nel Buddismo — ma non si può ad alcun patto espellere dalla religione, con un semplice Crux dixit,
6
gli altri elementi che quasi dappertutto la compongono: una metafisica (trascendentale) collegata a una teologia (scienza della divinità) e ad una mistica (unione colla divinità); e un culto (riti, sacrifizi, liturgia) esercitato in comune.
Una «concezione della realtà» che sia puramente umana, coll'esclusione di ogni trascendente e soprannaturale, non può esser fondamento d'una religione in senso proprio e, come dice il Croce, «intrinseco». L'uomo, per quanto l'abbia tentato, non può adorare e obbedire l'uomo. L'esperienza del «culto degli antenati» in Cina, del «culto imperiale» dell'età romana, della «religione dell'umanità» dei positivisti dimostra che l'uomo non può seriamente riconoscere come legittima ed efficace un'autorità religiosa che poggi nell'umano. Possono, gli uomini, venerare religiosamente certi uomini — gli Eroi della Grecia antica, Buddha, Maometto — ma solo in quanto son persuasi e certi che la loro umana natura fu trasformata e sublimata colla diretta partecipazione alla divinità: sia perchè assunti fra gli dei dopo la morte sia perchè investiti d'una missione divina che li fa simili agli dei.
E se il Croce, oltre che filosofo, fosse un tantino psicologo ne capirebbe subito la causa: ogni religione è, volere o no, un violentamento degli istinti umani primitivi, un tentativo di pedagogia inalzante: dall'anarchia alla legge, dalla ferocia alla pietà, dalla concupiscenza alla rinunzia. E gli uomini non s'adatterebbero mai a riconoscere una legge morale superiore se non la credessero rivelata; non sarebbero disposti a tollerare una disciplina limitatrice della libertà selvaggia se non fossero convinti ch'è voluta da un Potere superiore a qualsiasi potere umano; non si sentirebbero protetti e amati dall'Essere che li guida se non avessero la certezza che questo Essere è al disopra dell'umanità, che può e sa ciò che gli uomini mai potranno e sapranno. Gli uomini si rassegnano all'abdicazione ma purchè il nuovo sovrano sia d'altra natura e d'altra sfera. Anche senza voler accettare le posizioni estreme della nuova teologia tedesca di Barth e compagni — che tra l'umano e il divino ci sono possibilità di ascesa e perfin di unione — bisogna pur riconoscere the il presupposto d'ogni religione è la distanza e differenza incommensurabile tra l'uomo e Dio: la sicurezza che l'uomo non è Dio e Dio è tutt'altro che l'uomo.
Adorare un altro uomo, sinceramente, è impossibile: e quando gli uomini vi furon costretti dall'autorità non poteron far altro che fingere, per interesse o paura, e più gl'imperatori romani insistevano nel propagare il loro culto più le anime evadevano nelle religioni dei misteri e nel Cristianesimo. E invano Giuliano e Celso sostenevano che Gesù non era stato che un uomo come gli altri: i cristiani l'adoravano in quanto credevano fermamente che fosse stato non nomo soltanto ma vero Dio.
7
Ne si può seriamente parlare d'una «religione dell'umanità» o d'una «religione dello spirito umano» — prendendo cioè come oggetto di culto il genere umano invece che un singolo — perchè dell'umanità o dello spirito ognun di noi fa parte e il culto presuppose una distinzione tra l'adorato e l'adoratore. Senza contare che si tratta di concetti astratti e generici, incapaci per natura loro d'ispirare quel minimo di reverenza e d'amore ch'è indispensabile in ogni forma di religione, per quanto semplice sia. La religione propugnata dal Croce, cioè la «religione umana» o liberalismo, pub dare origine a una morale laica — scompagnata da sanzioni personali e perciò scarsamente efficace nell'animo dei più — e magari, a voler esser larghi, a un'ascesi filosofica e civica senza dubbio rispettabile ma senza che abbia nulla a che fare con quell'intimo calore e con quella sublimazione dell'animo dovuta alla fede in una Presenza sovrumana e sovrannaturale ch'è propria delle religioni nel vero e integrale senso della parola. Siamo nella religiosità: non c'è ancora la religione. La religiosità è vaga, la religione è precisa; la religiosità è puro pensamento o sentimento individuale, la religione è, sempre, fatto sociale, collettivo.
E quest'ultimo carattere ci porta a considerare l'altro elemento che n'è inseparabile: il culto. Ammessa necessariamente la trascendenza dell'oggetto da venerare ne viene per conseguenza la necessità di precisi rapporti tra i fedeli e il loro Dio. Non solo la preghiera che può essere, in certi casi, individuale e interiore — ma la preghiera in comune, un sacrifizio pubblico, un cerimoniale d'iniziazione e di riconciliazione: insomma una liturgia e una pratica sacramentale. E questi elementi non sono affatto, come ritiene il Croce, «estrinseci» ma intrinsicissimi, anzi essenziali, tanto necessari che nessuna religione, per imperfetta che sia, n'è priva. Anche se «religione» non deriva da «religare» resta pur sempre il fatto che ognuna di esse è, in ogni dove, un'ecclesia, cioè una riunione d'uomini. E quelli che formano le assemblee religiose non si riuniscono per guardarsi in viso, bensì per compiere insieme, affratellati in una fede comune, determinati atti e pronunciare determinate parole.
Se il Croce vuol imparare, ad esempio, qual valore concreto e insostituibile abbia la liturgia, favorisca di leggere i libri di Romano Guardini, italiano di nascita e tedesco di cultura, e che non dovrebb'essergli, perciò, troppo ostico 3.
3 Il più noto è Vom Geist der Liturgie. Freiburg i. B. Herder, 1918 (nella collezione Ecelesia orans). Di quest'operetta esiste ora una traduzione italiana (Lo spirito della Liturgia. Brescia, Morrelliana, 1930). Il Guardini, però non è i1 solo, in Germania e fuori, che abbia rivendicato l'essenzialità della Liturgia.
Soltanto attraverso la liturgia, cioè nella partecipazione effettiva e consapevole allo svolgimento di quel poema davvero umano e divino
8
ch'è l'anno ecclesiastico, il fedele diventa parte viva del gran corpo mistico ch'è la Chiesa. Quella bellezza dei riti, dei canti, dei simboli ammirata da non cattolici o da neo cattolici dilettanti non è, intendiamoci, benchè necessaria, l'elemento sostanziale: si tratta di andare dall'esterno all'interno, dal simbolo alla realtà significata, dalla cerimonia al dramma teandrico che i riti ricordano e rappresentano. Innanzi tutto la liturgia è veicolo di comunione tra i partecipanti; mirabil via per la comprensione dei misteri; istradamento a una vita sovrannaturale non semplicemente creduta ma sperimentata; mezzo certo per fare d'un gregge eterogeneo una comunità che lega insieme i singoli e inserisce la loro preghiera nella grande preghiera della Chiesa.
Tutte queste cose sembreranno al Croce ed ai suoi simili fantasie e illusioni d'ingenui ma, per il credente, son realtà indubitabili della sua coscienza e senza una tale certezza e partecipazione il credente non sarebbe tale. E al Croce non chiediamo di parlare come un cattolico ma, come nostro diritto, di capire cosa sia la religione e in particolar modo il Cattolicismo. E dovrebbe dunque capire, s'è onesto, che il culto fa necessariamente parte della religione quanto la cosmologia e l'etica e che senza un culto che unisce e affratella i fedeli religione non c'è. Senza giungere all'esagerazioni di un Durkheim, che nelle religioni vede soltanto una manifestazione del sociale, e gioco-forza ammettere che la religione non è concepibile come fatto individuale. Essa suppone, sempre, una società religiosa più o meno fortemente organata, e l'uomo è religioso in quanto partecipa alla vita di questa società mistica, com'è cittadino in quanto prende parte alla vita della propria nazione. Ma una società religiosa implica, oltre che un credo comune, anche un culto comune e, per conseguenza, quel «corpo sacerdotale» che il Croce reputa inutile o almeno inessenziale. Nessuna società può reggersi senza un codice riconosciuto e accettato, senza un'autorità che vegli all'integrità del comun credo e all'osservanza della legge e crea necessariamente nel suo seno dei capi (gerarchia del sacerdozio) e degli interpreti e maestri (teologi e moralisti).
Sicchè tutti quegli elementi che il Croce vorrebbe escludere dalla religione come estrinseci e aggiunti sono, al contrario, necessarissimi e strettamente collegati agli altri e quelle stesse religioni che in principio di tali elementi erano scarse — come il Buddismo e il Taoismo — hanno finito a poco a poco, per naturale necessità, coll'acquistarle.
Il Croce vorrebbe una religione ridotta a una pura teoria immanente dell'universo e ad una morale conforme a tale teoria. Ma non s'accorge ch'egli separa, a questo modo, ciò che non è separabile. La sua religione non è affatto religione ma una semplice concezione filosofica con l'appendice di un'etica e se può soddisfare — e difficilmente —
9
un uomo che sia ridotto al puro cervello, non risponde affatto a tutte l'altre esigenze, sentimentali, poetiche, umane nel pieno senso (filiali, fraterne) che l'uomo vuol soddisfare nelle religioni. A chi cerca un albero con tutta la ricchezza dei suoi rami, delle sue foglie, dei suoi fiori e dei suoi frutti il Croce offre un tronco nudo e piallato, tolto dal caldo humus della terra madre e a chi desidera una foresta, colle sue ombre e i suoi nidi, le sue luci e le sue calde radure, presenta un filare di manichi da granata. Se il Croce preferisce un palo astratto a una bella quercia faccia pure: contento lui contento nessuno. Ma sappia e si ricordi che l'uomo cerca nella religione un tempio completo e non soltanto un pensatoio o una cattedra.
Se nel Croce la vita affettiva è assente o repressa — come appare da certe sue confessioni — non dovrebbe per questo rifiutarsi di riconoscere, sia pur coll'intelletto solo, che la religione concreta non è soltanto un edificio intellettuale. È una forma di vita intera non un sistema di concetti. Tutte le potenze dell'animo, compresa l'intelligenza, vi partecipano: sensibilità, volontà, affetto. Vi sono religioni in cui predomina il timore, altre in cui predomina l'amore ma in tutte l'elemento affettivo — quale si manifesta nel culto e nella mistica — è predominante. Il liberalismo del Croce può essere un'aspirazione di certa borghesia intellettuale, un sistema aleatorio di governo, magari (scialiamo pure) un canone per interpretare la storia dell'Europa moderna ma non è e non può essere una religione. Almeno fino al giorno in cui S. M. Benedetto I, Czar di tutte le Culture, non rifaccia e stravolga, con ukase partenopeo, il vocabolario dei popoli civili.
Nella storia europea dell'Ottocento il Croce si trova dinanzi parecchie volte ii Cattolicismo e ne parla con quella pacatezza rispettosa ma formale che si usa tra potenza e potenza ma quasi sempre con aria tra l'infastidito e il nemico. Sembra di vedere un ingegner progressista, un po' bolso, un po' miope, un po' splenetico che giri per le strade d'una metropoli sognando sventramenti e piani regolatori. E dappertutto dove la sua razional fantasia di tecnico a spasso immagina un bel rettifilo o una piazzona quadrata si trova dinanzi una basilica romanica o una cattedrale gotica o un oratorio barocco e tra se bofonchia: Notevoli sotto il rispetto storico, importanti per l'architettura, si, ma che inciampi, che ingombri tutte queste chiese fra i piedi! E torna a casa lemme lemme, col suo pancettino in fuori, colla bocca un po' storta, per scrivere un altro libro sulla città liberale dell'avvenire.
10
Se il Croce trovasse da ridire sul Cattolicismo sotto l'aspetto politico non sarebbe gran male. Nessun cattolico onesto ha mai negato che la Chiesa abbia commesso, nel corso dei secoli, degli errori politici — benchè, a seconda degli ideali o dei partiti, quel che può sembrare errore a uno diventa somma saviezza per un altro. Ma giova avvertire che la vocazione e la destinazione della Chiesa non hanno nulla a che fare colla varia politica: l'assistenza dello Spirito Santo riguarda la sua attività spirituale più che quella politica. Per la Chiesa, posta in mezzo a un mondo spesso nemico e poco cristiano, la politica può essere una necessità non fine o ragione di vita.
Ma la cosa grave e che il Croce, forse senza avvedersene, dalla politica della Chiesa (secondo lui errata) deduce il suo giudizio ostile anche sulla Chiesa come società d'anime e siccome essa non aiutò, come sarebbe piaciuto a lui, il moto liberale, gli apparisce sorpassata, decadente e ormai quasi moribonda. Il Croce, vescovo in partibus infidelium della pseudo-religione liberale, può giudicare colla severità che vuole la religione rivale nell'ordine politico ma s'è anche storico, e storico onesto e informato, deve pur sapere che la vita della Chiesa in ben altro consiste e che le sue interferenze politiche non sono che una parte, e insomma subalterna e caduca, della sua multiforme e perenne attività. Gli storici comuni, che badano ai fatti prettamente politici, più appariscenti agli occhi del volgo, sono scusabili se parlano della Chiesa solo in rapporto alle sue posizioni verso gli stati e i partiti. Ma il Croce, giustamente, vuol fare storia completa, storia delle idee e delle coscienze, storia morale, dunque, e non solo civile, e dovrebbe tener conto del Cattolicismo nel suo ricco complesso. Non si può giudicare un artista o un filosofo dalle sue relazioni coi servitori, coll'agente delle tasse e col padron di casa e la sua poesia e il suo pensiero possono essere grandi anche se la sua condotta meramente pratica si presta a maligne censure.
E difatti c'è nel libro del Croce qualche accenno anche al Cattolicismo come organismo spirituale ma non sempre equanime e, soprattutto, non sempre fondato sopra un'informazione e comprensione sufficienti. Se là parlava il liberale inagrito qui parla il filosofo dell'idealismo e dell'immanenza.
Anche per il Cattolicismo, come per la religione in genere, il Croce procede per mutilazioni e asportazioni. Se vi sono filosofi, poeti, magari politici, che il Cattolicismo dell'Ottocento può rivendicare per suoi, e gloriarsene, il Croce avverte che costoro non valgon nulla o sono stati rifiutati dalla Chiesa o che in realtà non appartengono propriamente al Cattolicismo. Sistema, come si vede, comodissimo. Portate via a un disgraziato i soldi e i vestiti eppoi esclamate trionfalmente: Guarda un po' corn'è povero! che vergogna esser nudo!
11
«Il pensiero e la scienza continuarono a sfuggirle — scrive il Croce, senza neanche un'ombra di prova — il suo grembo era in ciò colpito di sterilità come a divino castigo per aver essa peccato contro lo spirito che è spirito di sincerità; e tutt'al più, in mezzo a quelle burrasche e a quelle paure, vide ergersi a suo campione qualche scrittore dottrinario bensì e polemico, ma fanatico e astrattamente logico e consequenziario, e amante dell'estremo e del paradossale, dal quale altresì ebbe piuttosto cagione di diffidenza che effettivo aiuto, fiutandone lo spirito estraneo e la pericolosa indipendenza» 4. Sono, come si vede, condanne generiche e non motivate. Se la Chiesa ha peccato contro lo spirito vuol dire che fu ipocrita: in qual senso, in qual modo? Consigliando l'obbedienza alle autorità? Ma questo consiglio è implicito nel Vangelo e in San Paolo. Predicando dottrine contrarie a quella di Cristo? Ma dove? E quali? Non praticando, in tutta la sua assoluta purezza, l'insegnamento evangelico? Ma questa accusa si poteva rivolgere anche a molti cristiani dei primi secoli e ancor più a quelli del Medioevo e nonostante Croce stesso riconosce che la Chiesa, fino alla Riforma, fu tutt'altro che sterile.
E quali sono i filosofi «fanatici» ai quali allude il nostro storico? Pensa, probabilmente, al Bonald e al De Maistre e anche, suppongo, al Moehler, ad Alberto Haller, al Goerres, forse ad altri ancora. Ma quali le ragioni per rigettarli così in blocco senza neppur nominarli? Il tradizionalismo esagerato del Bonald fu condannato dalla Chiesa ma il De Maistre è ancora molto letto, e non da soli cattolici, e nelle Soirées vi son pensieri che ancor oggi appaiono profondi a pensatori non volgari. La Simbolica del Moehler, fu giustamente definita l'opera più importante del Cattolicismo tedesco dopo la Riforma e lo stesso Croce difese la teoria dello Stato di Haller contro alcune ingiuste critiche di Hegel 5. E la Mistica di Goerres, per quanto invecchiata nei particolari, resta un modello di alta interpretazione della storia spirituale dell'uomo.
Parla, dopo, di «cattolicismo liberale» ed aggiunge subito: «nella qual denominazione è chiaro che la sostanza era nell'aggettivo, e la vittoria era riportata non dal cattolicismo ma dal liberalismo...» 6. È bensì vero che la Chiesa non guardò con molta simpatia a codesti «cattolici liberali» — benchè vi si possa includere, per un certo periodo, perfin lo stesso Pio 1X — ma non v'e nessuna ragione di ritenere e di affermare che in tali cattolici le simpatie per il liberalismo avessero attenuato o sopraffatto la fede. Con qual diritto, dunque, asserire che la «sostanza» era nell'aggettivo?
12
Ma ci son offese alla verità assai più gravi. Nel capitolo IV (Vittoria contro l'assolutismo) il Croce accenna agli scrittori di quel tempo e del Manzoni si sbriga così: «esso e gli altri della sua scuola appartengono alla cerchia liberate e non a quella cattolica o clericale, la quale, come non produsse pensatori o li produsse eterodossi o poco ortodossi, così non ebbe in Italia poeti ne scrittori di qualche conto» 7.
7 Storia di Europa. pag. 98. Neanche i Neoguelfi, secondo lui, furono autentici cattolici, e, fra l'altro, perchè antigesuitici e sotto l'influsso del Giansenismo (pag. :126-27).
Si può accordare, per amor di brevità e di pace, quel che riguarda i filosofi — se il Croce ha pensato al Günther, al Lamennais, al Rosmini e al Gioberti — ma quanto agli scrittori non arrivo a capire come il Croce sia arrivato a quella strabiliante affermazione.Negare al Manzoni la qualità di scrittore cattolico mi sembra, per non dir peggio, un trascorso di penna dovuto a mania illuminista. Che il Manzoni avesse simpatie per le idee liberali si può ammettere ma non vedo quale influenza abbiano avuto quelle simpatie sull'opere dove più si manifesta scrittore: poeta negli Inni sacri, pensatore nella Morale cattolica, narratore nei Promessi sposi. C'è' semmai, nel romanzo, un lieve sentore di democrazia, piuttosto che di liberalismo, cioè un amor forte per gli umili e un odio altrettanto grande per le ingiustizie dei potenti, ma nulla che possa dirsi, in senso stretto, liberale. In quell'opere il Manzoni è, oltre che grande artista, cristiano grandissimo; d'un Cristianesimo che non è propriamente quello mistico e medievale ma razionabile e cordiale, più moralistico che ascetico, più francese che francescano ma insomma pur sempre Cristianesimo. E come potrà dire il Croce che scrittori come il Tommaseo, il Capponi, il Balbo, il Cantù siano scrittori di nessun conto? Gli abbandono, se vuole, il Padre Cesari e il Padre Bresciani ma dove trova il Croce, fuor del Manzoni e del Leopardi, prose così lucide, vivide e solide come quelle dei primi due ricordati, l'esule dalmata e il marchese fiorentino?
E nella stessa pagina il Croce ne dice una ancora più grossa: «Priva perciò [la Chiesa] del suo elemento vivificatore, e incapace di generare nuove forme e persino nuovi ordini religiosi...» 8. Qui si tratta, mi dispiace, d'una questione di fatto. Se il Croce, gran lettore di storie, si fosse degnato di sfogliare una qualsiasi storia della Chiesa avrebbe visto che nuovi ordini sorsero, numerosissimi, nel periodo da lui considerato. Basta ricordare la Congregazione di Picpus, per le missioni straniere, fondata nel 1801 e approvata da Pio VII net 1817 col nome di «Société des Saints Coeurs de Jesus et de Marie»; gli Oblati di Maria Immacolata fondati dal p. E. De Mazenod nel 1816; i Maristi fondati nello stesso anno dall'abate Colin; i Frères de l'Instruction
13
chrétienne (ricordati dallo stesso Croce a pagina 99) istituiti nel 1816-20 dal fratello del Lamennais; le Dame del Sacro Cuore fondate nel 1800 da Santa Maddalena Sofia Barat; le Giuseppine che risalgono al 1819; le Suore del Buon Pastore sorte nel 1829, senza contare altre congregazioni minori create in quegli anni o quelle, importanti, sorte poco dopo il '3o (gli Assunzionisti nel 1840, le Suore di Carità nel 1835, i Salesiani nel 1855).
Ma il chiodo fisso del Croce è che il Cattolicismo si trova «da più secoli in condizioni d'inferiorità intellettuale» 9 e incapace di giustificare razionalmente la sua pretesa all'assoluta verità. «Che l'ideale di un ordine trascendente di verità, di regola morale e pratica, e di congiunto governo dall'alto e dal cielo, esercitato in terra da un pastore e rappresentato da una Chiesa, non si sia neppur oggi integrato di quell'intrinseca giustificazione mentale, della quale, nel corso dei secoli, si era scoperta in esso la mancanza, è ovvio, e quasi spiace insistervi come in tutte le polemiche che si muovono nell'ovvio e che c'è rischio che sembrino ingenerose» 10.
Non abbia temenza, il Croce, di sembrare ingeneroso: gli perdoneremo anche questa. E ci spieghi in cosa consisterebbe, secondo lui, quell'«intrinseca giustificazione mentale» che manca al Cattolicismo. Se desidera conoscere i motivi di credibilità e le prove storiche e teologiche sulle quali si appoggia la giustificazione umana del Cattolicismo c'è una biblioteca di apologisti a sua disposizione e non ha che da scegliere. Ma se poi intendesse per «giustificazione mentale» una dimostrazione che partisse da verità accettate o credute da lui e dai suoi pari è chiaro che domanda l'assurdo e l'impossibile. Egli nega ogni trascendente, ogni soprannaturale, e relega tra i problemi inesistenti o irrilevanti quelli che si riferiscono all'esistenza d'Iddio, alla possibilità dell'Incarnazione, all'immortalità dell'anima, come vuol mai che il Cattolicismo possegga o escogiti una «giustificazione mentale fondata sulla negazione radicale delle nozioni sulle quali si fonda? Sarebbe lo stesso che uno scettico esigesse una «giustificazione mentale» del realismo o dell'idealismo fondata sullo scetticismo, cioè capace di negare lo scetticismo partendo dalle tesi scettiche. Una «giustificazione mentale» non è comprensibile che fra spiriti i quali ammettono alcunchè di comune: tra i cattolici e Croce non v'è di comune, e solo fino a un certo punto, che la legittimità dell'uso della ragione. Se tutta la filosofia cattolica, da Sant'Agostino a Peter Wust, è per lui inficiata dall'ammissione della trascendenza, come può pretendere che una giustificazione
14
cattolica, anche esposta da pensatori di genio, riesca ad esser valida per lui?
E il Croce dimentica che alla fede cattolica — che sol in parte, come s'è visto, è costruzione mentale — non si arriva soltanto per la via della ragione. La Chiesa insegna, giustamente, che le verità della fede sono dimostrabili anche per l'intelletto ma al disopra dell'intelletto c'è l'illuminazione, la grazia, ciò che il Pascal chiamava l'ordre de la charité.
Eppure lo stesso Croce, nel Libro dei Pensieri, ha presentito, sia pure movendo da una pretesa eretica (la rinunzia alla teologia), che nella religione c'è altro che non è pura teoria e che infine è l'essenziale. Parla, difatti, di «un mero stato d'animo, in cui si è o non si è, a cui si partecipa o non si partecipa. Contro speranze e attese oltremondane [e molte altre speranze si potrebbero aggiungere] il filosofo non potrebbe muovere alcuna obiezione: come non può farne a un Petrarca che ami una Laura: uno stato d'animo ha il diritto di essere anche sospeso o rotto da contrasti, e, in un certo senso, tale è sempre» 11. C'è, qui, una parte della verità, di quella che nella Storia di Europa il Croce tace o disconosce. E anche l'esempio del Petrarca, benchè profano, può servire a condurre la mente del Croce verso la verità. Il Cristianesimo è, nel suo nucleo originario e sempre vivente, amore: amore del Padre, amore del Cristo, imitazione di Cristo in quanto Cristo, perfetto, è degno d'essere amato e imitato; amore di Dio per gli uomini (manifestatosi sommamente nella Redenzione); amore degli uomini verso Dio (sempre insufficiente e tiepido, fuor che nei Santi); amore dell'uomo per tutti gli uomini in quanto figli d'uno stesso Padre, corredenti dal medesimo Figlio.
E come potrebbe l'amore — fuoco di carità e di sacrificio — presentare in bei sillogismi la sua «giustificazione mentale» al filosofo Croce, che diffida, per congenita gelidità, del sentimento e dei sentimentali? L'amore può offrir di meglio: una giustificazione storica, una giustificazione umana che dura da diciannove secoli: i mutamenti morali da esso portati nella vita e nell'anime degli uomini, la storia delle sue opere di carità, così malnote ai pensatori di gabinetto; l'esercito immenso dei suoi apostoli, dei suoi martiri, dei suoi beati. La giustificazione massima del Cattolicismo è in un'opera che il Croce, con tutta la sua dottrina, non ha l'abitudine di leggere: negli 4cta Sanctorum dei Bollandisti 12.
12 Il Croce «percorre», bensì, vite di santi ma solo dell'Italia meridionale e unicamente
per pescarvi notizie e curiosità storiche e di costume, cioè tutto men che l'anima del santo! Vedi la sua strana confessione in Critica, XXIX (1931), pag. 310.
15
.
Il Croce sarebbe disposto, bontà sua, a tollerare l'esistenza agonica del Cattolicismo e magari a mantenerlo, a spese del liberalismo, nel museo archeologico della storia, ma non può rassegnarsi al pensiero che molti uomini, d'altra fede, o di nessuna fede, sian tornati o tornino di continuo alla Chiesa di Roma. Egli è talmente immassimato nell'idea fissa che il Cattolicismo è vieto e incadaverito che non sa persuadersi come esso possa ancor conquistare anime vive. Si direbbe che fanno un dispetto personale a lui, talmente sicuro e tranquillo nella sua caverna ghiacciata dell'idealismo postkantiano.
Non li comprende, i convertiti, eppure vuol giudicarli: anzi si arrischia, con quella sua aria di pontefichino infallibile, a decidere quali siano i motivi interni e veri di tali conversioni. E non v'è da meravigliarsi se non ne azzecca una.
Quanto ai convertiti dell'epoca romantica furono, secondo lui, anime femminee, fantasiose, estetizzanti e, al solito, poco ortodosse. «Quel loro Cattolicismo troppo abbondava nel senso e nella immaginazione, troppo spasimava per colori, musiche, canti, antiche cattedrali, figure di madonne e di santi, troppo si crogiolava nella voluttà del peccato, della penitenza e del pianto...» 13. Io non posso, qui, ritessere la storia delle conversioni al tempo romantico, che furon moltissime, e anche in paesi, come la Russia, lontani da Roma e dalla sua cultura, ma se il Croce vorrà, tornando sull'argomento, informarsi meglio si accorgerà che il suo giudizio non risponde che ad una parte sola di quelle conversioni. Che nel ritorno al Cattolicismo di alcune nature poetiche c'entrasse anche il lato, diciamo così, patetico ed estetico non è da negarsi e ne abbiamo esempi illustri nello Chateaubriand e nel Brentano. Ma non bisogna fermarsi, trattandosi di religione, soltanto ai casi dei poeti che, per essere più popolari e clamorosi, non sempre sono i più significativi. E del resto c'è, proprio in Italia, l'esempio della conversione d'un poeta che non fu preparata né accompagnata né seguita da quelle cose che il Croce enumera nella sua diagnosi. Non sappiamo con sicurezza la storia interiore della conversione manzoniana ma si può supporre ragionevolmente che fu preparata da serie riflessioni, provocata da una scossa emotiva, giustificata e rassodata da meditazioni e ricerche dottrinali e storiche. E il caso del Manzoni è, in quel tempo, tutt'altro che unico: Adamo Miiller fu portato al Cattolicismo da ragioni filosofiche; Alberto Haller attraverso la filosofia politica; Goerres passò dal sincretismo simbolico alla Chiesa in forza d'una sua filosofia della storia; lo Hurter fu convertito
16
dall'attento studio della storia, specie medievale; il Gratry per considerazioni puramente teoriche e quasi scientifiche; Donoso Cortes dalle sue esperienze politiche. E se ne potrebbero citare altri a dozzine, di convertiti che non furon sedotti dalle immagini delle Madonne, né dal pianto, né dalla bellezza delle cattedrali e che furon sempre schiettamente fedeli al dogma e al Papa. Non bisogna giudicare i romantici cattolici attraverso uno Stolberg o un Werner e anche nei casi di questo genere è onesto avvertire che a tali conversioni non contribuirono soltanto motivi emozionali ed artistici. A uno storico si ha il diritto di chiedere il pieno rispetto ai fatti storicamente sicuri: a tutti, non a qualcuno scelto arbitrariamente per comodità d'una tesi o sfogo di malumore.
Ma le conversioni che maggiormente indispettiscono il Croce son quelle recenti, quelle, cioè, di cui parla nell'epilogo e che son avvenute, perciò, durante o dopo la guerra: «il Cattolicismo, che già aveva tentato di ripigliare forza attraverso l'irrazionalismo e il misticismo, ha accolto e viene accogliendo, in gran numero, anime deboli o indebolite e torbidi e malfidi avventurieri dello spirito» 14. «Comunque, il motivo spirituale che ha spinto i migliori di costoro a rifugiarsi o a tornare al Cattolicismo... è stato non altro che il bisogno, nel tumulto delle idee, e dei sentimenti cozzanti e cangevoli, di una verità fissa e di una regola imposta: ossia una sfiducia e una rinunzia, una debolezza e un puerile spavento innanzi al concetto dell'assolutezza e relatività insieme di ogni verità e all'esigenza della continua critica e autocritica onde la verità a ogni istante si accresce e si rinnova. Ma un ideale morale non può conformarsi alle occorrenze dei deboli, degli sfiduciati e dei paurosi» 15.
E qui cercherò davvero d'esser cristiano, cioè disposto al perdono, perché le cose si fanno particolarmente gravi. Sentenziare senza ombra di prova, senza vera conoscenza degli accusati, senza un'idea precisa di quel che sia lo stato d'animo dei cristiani, che tutti i convertiti ultimi sono, senza eccezione, o vigliacchi o avventurieri è più da libello che da libro che s'intitola storia. Ma vorrei, sinceramente, che il Croce conoscesse più davvicino o, meglio, per esperienza propria, quale sia la condizione spirituale del cattolico. L'idea che la conversione dia senz'altro al convertito la pace assoluta, la sicurezza, la certezza e il riposo perpetuo d'ogni pena e lotta è un'idea che può sorgere soltanto in colui che non è mai stato veramente cristiano o non conosce, neppur di vista, le confidenze e le confessioni dei cristiani sinceri. Sappia il Croce che in costoro risorgono, benché sempre sciolti e vinti, dubbi sulla fondatezza della lor fede; dubbi sulla capacità di giungere alla perfetta salvezza;
17
insofferente dinanzi alla grossolanità o tiepidezza della maggior parte dei loro nuovi compagni; periodi tristi d'aridità; inquietudini e tentazioni d'ogni sorta. Altro che tranquillità e quiete a ristoro della presunta debolezza! Il cristiano sul serio è in perpetua guerra e tormento e se qualcuno dice di non aver mai avuto dubbi e travagli stia sicuro il Croce che si tratta d'un cristiano torpido e tardo oppure, in quel momento, non sincero.
Il Cattolicismo sarebbe un asilo contro le agitazioni dello spirito e la paura? Ma non ha mai pensato, il Croce, che proprio il Cristianesimo fa sorgere paure tali che soltanto i forti le possono sopportare? Timore d'errare, sia nel pensiero che nella pratica; timore di perdere la Grazia; timore di non poter giungere alla beatitudine; timore dell'autorità, che giustamente vigila più dappresso i nuovi venuti; timore, infine, della giustizia d'Iddio. E che razza di paurosi sarebbero mai costoro che, per sfuggire alla paura dell'incertezza o dell'autocritica, si precipitano in un abisso di paure?
Con questo non voglio dire che il cristiano sia, sempre, una creatura tremebonda e dilaniata: vi sono remissioni dolcissime, conforti ineffabili, entusiasmi fecondi. Ma il Croce, che si compiace spesso di parlare d'una assolutezza ch'è relativa, di un oggetto ch'è pur soggetto, d'un errore ch'è insieme verità, dovrebbe, meglio d'altri, arrivare a capire una sicurezza ch'è inquietudine, un riposo ch'è battaglia, una protezione ch'è rischio, una pace ch'è timore. E tale, se ne rammenti, è lo stato d'animo dei cattolici il cui Cattolicismo non consiste soltanto nell'andare alla Messa tutte le domeniche e nel confessarsi per Pasqua.
Ma chi sono, poi, questi paurosi, questi deboli, questi avventurieri che si son convertiti negli ultimi anni? Son molti, certo, ma badi che i più tra i convertiti ora viventi e operanti (da Claudel a Maritain, da Gemelli a Giuliotti) si son convertiti prima della guerra: suppongo, dunque, che non voglia parlar di loro.
Tra quelli più noti, degli ultimi venuti, si può ricordare, credo, un francese: Jacques Rivière; un inglese: G. K. Chesterton; un tedesco: Peter Wust; e un italiano: colui che scrive queste pagine. Non son tutti, ma rappresentano, insomma, varie classi di spiriti e i maggiori paesi colti d'Europa.
Il Rivière, veramente, fin dal 1907 sentì il bisogno della fede 16
16 Si vedano le sue lettere a Claudel, J. Rivière et P. Claudel, Correspondance, 1907-1914. Paris, Plon, 1926.
e si comunicò per la prima volta al Natale del 1913. Ma solo durante la sua prigionia in Germania poté ricercare ed elaborare le ragioni della sua fede e se ne posson vedere i resultati in due libri pubblicati dopo la sua morte: A la trace de Dieu (1925); De la sincerité envers soi-méme18
(1925). È difficile trovare uno spirito più fine, autocritico e leale di quello del Rivière: sottile, inquieto, severo verso sé stesso, entusiasta e nello stesso tempo guardingo e sorvegliato: cervello d'intellettuale ardente e cuore d'artista. Si leggano le sue lettere e i suoi libri: non v'è traccia alcuna di quella paura, di quella debolezza, di quell'aspirazione a una requie vile che secondo il Croce sono i maggiori moventi d'una conversione.
Anche il Chesterton si poteva dir cattolico, come forma mentis, fin da quando pubblicò Heretics (1905) e soprattutto Orthodoxy (1908) ma siccome non è entrato ufficialmente nella Chiesa fino al 1922 può esser considerato, a scelta, tra i «deboli» o tra gli «avventurieri». Basta, però, leggere un sol volume suo per accorgersi che non può esser messo né tra gli uni né tra gli altri. Il Chesterton, anche quando par che faccia il chiassone e il forzatore, è sempre profondamente serio. È venuto alla Chiesa per un bisogno intellettuale d'armonia intera e coerente non già per colpo di fulmine o per vaghezza dei santi dipinti o delle pompe del culto. E non è entrato perché avesse paura delle ricerche e novità moderne, per paradossali o estreme che fossero, ché anzi il suo spirito pronto e ardito ci sguazzerebbe dentro meglio che nell'ortodossia. Ma ha visto, dopo lunghe esperienze e meditazioni, che soltanto nel Cattolicismo tutte le attività migliori dell'anima e del corpo trovano la piena loro soddisfazione e conclude che «l'ortodossia non è soltanto, come si dice spesso, la sola custode di una moralità e dell'ordine, ma anche l'unica salvaguardia logica della libertà, dell'innovazione e del progresso». Ecco dunque un uomo moderno, coltissimo, che non si fa cattolico per paura della libertà o per nostalgia del passato. E in Chesterton, nella vita e nell'opera, altro che debolezza! Pochi uomini sono al mondo, oggi, che manifestano una tale vivacità d'intelletto, una vitalità così piena, lieta, lussureggiante. In questo inglese nato nell'epoca vittoriana par che sia risorto qualcosa della sanguigna e sprizzante rigogliosità degli elisabettiani.
Peter Wust, nato cattolico, s'era gettato ai primi del secolo nell'idealismo e nello scetticismo. Una parola che udì, il 4 ottobre 1918, dal famoso Troeltsch — si badi, protestante — lo indusse a riesaminare i fondamenti della filosofia moderna. E quando uscì, nel 1920, il suo primo libro importante (Die Auferstchung der Metaphysik) era passato dall'idealismo al Cattolicismo e, si noti, per ragioni prevalentemente speculative 17.
17 Si veda, fra gli altri libri venuti dopo, Die Rückkehr aus dem Hexil (1924); Naivitat und Pietat (1925); e specialmente Die Dialektik des Geistes (1928).
Si posson notare, in lui, le influenze di due poeti, il Blake e il Claudel, ma la via percorsa per tornare alla fede — dopo il passaggio
19
attraverso quella che il Croce ritiene il vero crisma delle intelligenze moderne, cioè l'idealismo — è filosofica: dall'immanenza alla trascendenza, dall'io a Dio. E qualunque sia l'opinione che si possa avere del suo sistema è certo che si tratta d'un pensatore vigoroso, preparato, coltissimo e ancora nella pienezza delle forze (è nato nel 1884). E a questo proposito converrà osservare che questi cosiddetti «deboli» si convertono tutti nella gioventù o nella vigorosa virilità: Rivière a 27 anni; Chesterton a 34; Peter Wust a 36. Ed io cominciai a scriver la Storia di Cristo nel 1919, a 38 anni.
Debbo per forza parlar di me e anche se il Croce, che mi reputa esibizionista, non ci crederà, a malincuore. Ma tra coloro ch'egli definisce «torbidi e malfidi avventurieri dello spirito» ha voluto certamente alludere anche a me e, forse, principalmente a me. E vuol sapere il Croce come io sono stato condotto al Cattolicismo? Non ho mai voluto scrivere, benché ripetutamente sollecitato, la storia del mio ritorno a Cristo ma per dimostrare al Croce ch'io non mi sento offeso dai suoi acerbi e talvolta ingiusti giudizi 18
18 L'ultima volta che il Croce ha parlato di me è stato per fare una recensione del mio libro Gli operai della Vigna (Critica, XXVII, 1929, pag. 157) nella quale asserisce fra l'altro, ch'io mi atteggio «a ingiuriatore e calunniatore». Ora, neanche a farlo apposta, negli Operai della Vigna non ci sono che elogi, panegirici e affettuose rivendicazioni!
voglio fare un'eccezione per lui. Sarò, naturalmente, brevissimo. Durante la guerra, e specie negli ultimi tempi, fui profondamente rattristato dallo spettacolo di tante rovine e di tanti dolori. Di lettura in lettura io venni risospinto alla lettura del Vangelo, che avevo letto più volte ma sempre con spirito diffidente e ostile. E meditando sul Vangelo, e specie sul Sermone del Monte, venni a pensare che l'unica salvezza per gli uomini, e una salvaguardia sicura contro il ritorno degli orrori presenti, non poteva essere che un mutamento radicale dell'anime: il passaggio, cioè, dalla ferinità alla santità, dall'odio per il nemico (e perfin per l'amico) all'amore anche per il nemico. Il Cristianesimo mi apparve dunque, in un primo tempo, come un rimedio ai mali dell'umanità ma, proseguendo nelle mie solitarie e ansiose meditazioni, venni a persuadermi che il Cristo, maestro d'una morale così opposta alla natura degli uomini, non poteva essere stato soltanto uomo ma Dio. E a questo punto intervenne, io credo, l'opera segreta ma infallibile della Grazia. E tanto era forte in me l'amore per quel divino maestro dell'amore ch'io decisi di far qualcosa, perché le sue parole giungessero anche a quelli che non le conoscono o non le intendono o le sprezzano. E incominciai a scrivere, solo, in campagna, non spinto da brame di acquietamento o di fortuna ma dal sincero bisogno di giovare a qualche mio fratello, la Storia di Cristo. E finita che fu mi si presentò l'esigenza di appartenere alla società fondata da Cristo. E tra le Chiese innumerevoli che si dicono20
sue fedeli interpreti scelsi, non senza contrasti interni e qualche repugnanza ora superata, quella Cattolica, sia perché essa rappresenta veramente il tronco maestro dell'albero piantato da Gesù ma anche perché, a dispetto delle debolezze e degli errori umani di tanti suoi figli, essa è quella, a parer mio, che ha offerto all'uomo le condizioni più perfette per una integrale sublimazione di tutto l'esser suo e perché in essa soltanto mi parve che fiorisse abbondante e splendente il tipo d'eroe che ritengo il più alto: il Santo.
Non dico che la via da me, senza volere, seguita, sia la migliore né tanto meno ch'io sia diventato un perfetto cristiano: ci vuol altro! Ma il Croce, se vuol credere a questa succinta ma sincera confessione, si persuaderà ch'io non fui trascinato a convertirmi né da una qualsiasi debolezza — avevo 38 anni né temevo le fatiche del pensiero e dello studio — né dal desiderio di rifugiarmi in un asilo comodo — ché anzi l'opera più difficile e dolorosa, per il cristiano, comincia proprio dopo la conversione — né per ignobili smanie di notorietà, ché nel 1921 già ero noto abbastanza in Italia e fuori. Dopo la conversione ho corroborato e confortato la mia fede con nuove ragioni, specie d'ordine storico e logico, ma resta il fatto che il primo impulso mi venne da un prepotente desiderio di servire agli uomini, di manifestar loro, nel modo che meglio potevo, il mio amore per loro. Se questi son sentimenti che possano muovere e infiammare un «torbido e malfido avventuriere dello spirito» lascio giudicare ai galantuomini e, prima che agli altri, al Croce medesimo. Il quale dovrà convenire, poi, che un «avventuriere» il quale resta nella stessa casa per dodici anni di fila e non ha nessuna voglia di lasciarla ma sol di rendersene più degno è un ben singolare «avventuriere».
Da molti anni mi ero astenuto dal discorrer pubblicamente intorno a Benedetto Croce e anche questa volta, per dir la verità, ne avrei fatto volentieri a meno, se alcune cose da lui affermate in questo libro non avessero profondamente ferito — oltre che la verità storica — la mia coscienza di uomo e di cristiano. Può darsi che in anni lontani io sia stato ingiusto verso di lui, almen nell'espressione dei miei dissensi, trasportato dalla galloria giovanile e, se questo fosse, ne faccio qui pubblica ammenda e gli chiedo candidamente perdono 19.
19 Difatti nell'edizione definitiva delle Stroncature che sta per uscire nelle mie «Opere complete» ho tolto quegli scritti sul Croce che non erano di pura discussione teorica.
Ora, se ne persuada, egli non m'ispira più avversione o dispetto ma una sincera pena. Com'egli stesso racconta nel Contributo alla critica di me stesso
20.
21
perse la fede cattolica ancor giovinetto, senza strappi, quasi senza accorgersene e non ha fatto mai nulla, divenuto adulto e ormai quasi vecchio, per conoscere e comprendere, nella sua vera essenza e nella sua mirabil pienezza, il tesoro che ha perduto. Egli è spirito troppo esperto e serio per non sentire il bisogno d'una religione ma si contenta, come s'è visto, d'una religione tra moralistica e civica, tutta teorica, che non merita in nessun modo il nome di religione. Gli manca, purtroppo, il senso dell'infinito, il senso del peccato, il senso della carità calda e operante. In lui la memoria e l'intelletto hanno occupato a poco a poco tutto l'uomo. Egli sa che l'uomo non è solo corpo ma anche anima eppur non arriva a comprendere, con tutta la sua intelligenza, che l'anima non è solamente intelligenza.
Gli manca, perciò, l'appercezione viva di ciò che sovrasta la pura ragione, di ciò che s'inalza, pericoloso ma prezioso, sulle più alte cime: la grande metafisica, la grande poesia, l'entusiasmo che rischiara anche l'intelletto col suo incendio, quell'amore che fa comprendere anche l'incomprensibile, che trova naturale anche l'assurdo e facile l'impossibile. È l'uomo magazzino, l'uomo officina non l'uomo torre, l'uomo cattedrale. È nato per l'onesta pianura, per i modesti altipiani: l'Alpi e il cielo non l'attirano e quasi gli repugnano.
È un cervello ben mobiliato e potente ma gli fan difetto le raisons du cceur e, perché non le possiede, le sprezza. Né possiamo fargliene colpa: non si nasce come dagli altri si vorrebbe ma come ci fanno. E i lampi sono inutili al cieco e vani sono i tuoni per il sordo.
Ma siccome ho almen cinque ragioni di volergli bene — ch'è un uomo, un italiano, uno studioso, un infelice e infine un nemico — non posso né voglio abbandonarlo. Anche l'antagonismo crea un legame e degli obblighi. E ho voluto scriver queste pagine proprio per lui, colla speranza ch'egli voglia riesaminare certi problemi, ristudiare con maggior simpatia certe vicende e certe anime; colla speranza, non disgiunta da una preghiera, che giunga anche per lui — meglio disposto ad accogliere l'opera della Grazia — l'ora dello sghiacciamento, il giorno felice d'una inconfutabile rivelazione.
◄ Indice 1932
◄ Nuova Antologia
◄ Cronologia